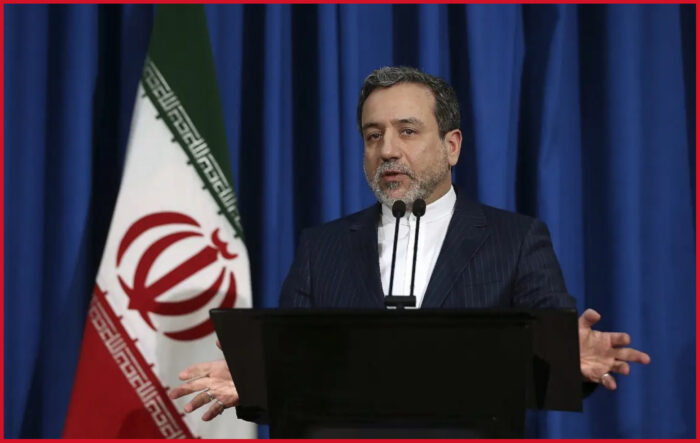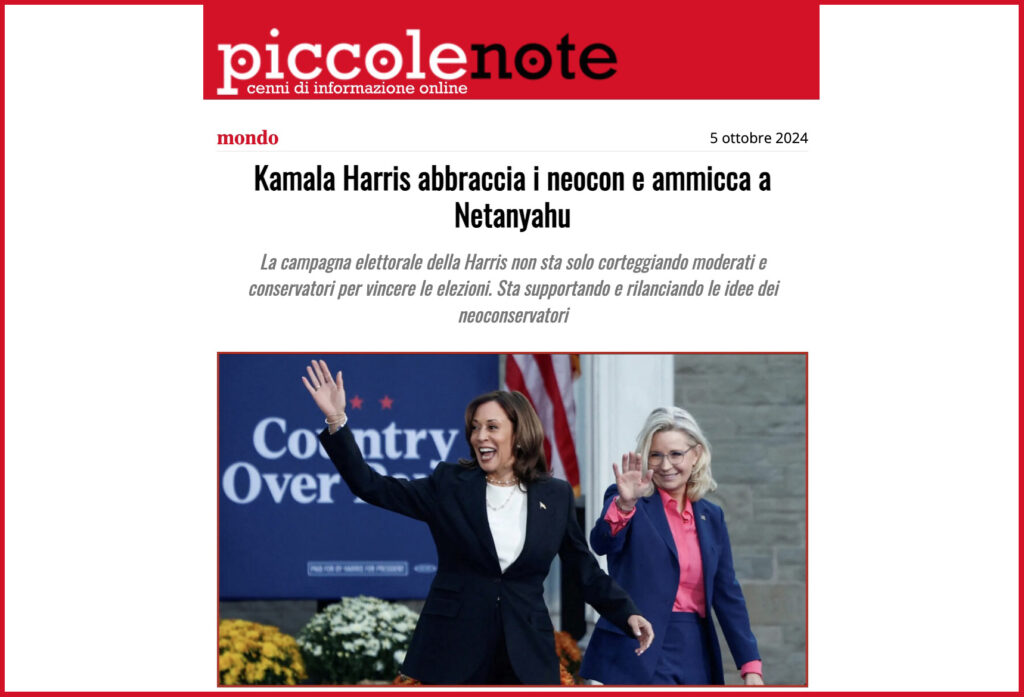di Scott Ritter* - ConsortiumNews
Lo scoppio del conflitto tra Iran e Israele sembra aver modificato la
posizione iraniana contro il possesso di un'arma nucleare, poiché
Israele è pronto a colpire dopo la rappresaglia di Teheran con due
grandi attacchi di droni e missili balistici e da crociera.
Da aprile l'Iran ha rilasciato almeno tre dichiarazioni attraverso i
canali ufficiali che hanno aperto la porta alla possibilità di revocare
gli editti religiosi contro l'acquisizione di armi nucleari.
Le circostanze che, secondo l'Iran, devono esistere per giustificare questa inversione di rotta sembrano ora essere soddisfatte.
Non si tratta di semplici minacce, ma di dichiarazioni politiche che
indicano che l'Iran ha già preso la decisione di dotarsi di un'arma
nucleare, che i mezzi per farlo sono già pronti e che questa decisione
può essere attuata nel giro di pochi giorni, una volta impartito
l'ordine politico finale.
La fatwa religiosa contro il possesso di armi nucleari è stata emessa
nell'ottobre 2003 dalla Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali
Khamenei. Essa recita:
“Crediamo che l'aggiunta di armi nucleari e di altri tipi di armi
di distruzione di massa, come le armi chimiche e le armi biologiche,
siano una grave minaccia per l'umanità...[consideriamo] l'uso di queste
armi come haram (proibito), e lo sforzo per proteggere l'umanità da
questo grande disastro è un dovere di tutti”.
Tuttavia, la fede sciita ritiene che le fatwa non siano
intrinsecamente permanenti e che i giuristi islamici possano
reinterpretare le scritture in base alle esigenze del tempo.
Poco dopo che l'Iran ha lanciato l'Operazione True Promise contro
Israele in aprile, Ahmad Haghtalab, un comandante del Corpo delle
Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) responsabile della sicurezza
dei siti nucleari iraniani, ha dichiarato:
“Se [Israele] vuole sfruttare la minaccia di attaccare i centri
nucleari del nostro Paese come strumento per fare pressione sull'Iran, è
possibile e immaginabile rivedere la dottrina e le politiche nucleari
della Repubblica Islamica dell'Iran per deviare dalle considerazioni
precedentemente enunciate”.
A maggio, Kamal Kharrazi, ex ministro degli Esteri che consiglia la
Guida suprema, ha affermato: “Noi [l'Iran] non abbiamo deciso di
costruire una bomba nucleare, ma se l'esistenza dell'Iran dovesse essere
minacciata, non ci sarà altra scelta che cambiare la nostra dottrina
militare”.
All'inizio di questo mese i legislatori iraniani hanno chiesto
una revisione della dottrina di difesa dell'Iran per considerare
l'adozione di armi nucleari, dato che il rischio di escalation con
Israele continua a crescere. I legislatori hanno osservato che la Guida
Suprema può riconsiderare la fatwa contro le armi nucleari sulla base
del fatto che le circostanze sono cambiate.
Queste dichiarazioni, viste nel loro insieme, costituiscono una forma
di politica dichiarativa che, date le fonti coinvolte, implicano che
sia già stata presa la decisione politica di costruire una bomba
nucleare una volta soddisfatto il criterio di sicurezza nazionale.
Ha la capacità
Da tempo l'Iran possiede la capacità di produrre e armare ordigni
esplosivi nucleari. Utilizzando uranio altamente arricchito, l'Iran
potrebbe costruire in pochi giorni una semplice arma a cannone che
potrebbe essere utilizzata in una testata di missile balistico.
A giugno l'Iran ha informato
l'AIEA che stava installando circa 1.400 centrifughe avanzate
nell'impianto di Fordow. In base a calcoli derivati dalle scorte
iraniane di esaflouride di uranio arricchito al 60% (la materia prima
utilizzata nell'arricchimento tramite centrifuga), l'Iran potrebbe
produrre abbastanza uranio altamente arricchito (cioè superiore al 90%)
per fabbricare 3-5 bombe all'uranio in pochi giorni.
Tutto ciò che serve è la volontà politica di farlo. Sembra che l'Iran
abbia superato questa soglia, il che significa che il calcolo alla base
di qualsiasi attacco israeliano e/o statunitense all'Iran è cambiato
per sempre.
L'Iran non ha fatto mistero di questa nuova realtà. A febbraio, l'ex
capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica, Ali-Akbar Salehi, ha
dichiarato che l'Iran ha superato
“tutte le soglie scientifiche e tecnologiche del nucleare” per
costruire una bomba nucleare, osservando che l'Iran ha accumulato tutti i
componenti necessari per un'arma nucleare, tranne l'uranio altamente
arricchito.
Due settimane dopo, Javad Karimi Ghodousi, membro della Commissione per la sicurezza nazionale del Parlamento iraniano, ha spiegato
che se la Guida suprema “desse il permesso, saremmo a una settimana dal
testare la prima [bomba nucleare]”, aggiungendo poi che all'Iran “serve
mezza giornata o al massimo una settimana per costruire una testata
nucleare”.
Una semplice arma nucleare a cannone non avrebbe bisogno di essere
testata - l'ordigno “Little Boy” sganciato su Hiroshima dagli Stati
Uniti il 6 agosto 1945 era un ordigno a cannone ritenuto così affidabile
da poter essere utilizzato operativamente senza alcun test preliminare.
L'Iran avrebbe bisogno di una quantità di uranio altamente arricchito
compresa tra 75 e 120 libbre per ogni ordigno di tipo gun (più
sofisticato è il progetto, meno materiale sarebbe necessario). Ad ogni
modo, il carico utile del missile ipersonico a combustibile solido
Fatah-1, utilizzato nell'attacco del 1° ottobre contro Israele, è di
circa 900 libbre, una capacità più che sufficiente per trasportare
un'arma all'uranio di tipo gun.
Dato che lo scudo antimissile balistico che copre Israele non è stato in grado
di intercettare il missile Fatah-1, se l'Iran dovesse costruire,
dispiegare e impiegare un missile Fatah-1 armato di armi nucleari contro
Israele, c'è una certezza quasi del 100% che colpirebbe il bersaglio.
L'Iran avrebbe bisogno di 3-5 armi nucleari di questo tipo per
distruggere completamente la capacità di Israele di funzionare come
nazione industriale moderna.
Conseguenze dell'uscita dall'accordo sul nucleare iraniano
Questa situazione si è creata dopo che il Presidente Donald Trump,
nel 2017, ha ritirato gli Stati Uniti dal Joint Comprehensive Plan of
Action (JCPOA), meglio conosciuto come accordo sul nucleare iraniano. Il
fattore trainante della negoziazione del JCPOA, avvenuta sotto il
presidente Barack Obama, era quello di bloccare il percorso dell'Iran
verso l'arma nucleare.
Come ha detto Obama, “in parole povere, questo accordo prevede un
divieto permanente per l'Iran di avere un programma di armi nucleari e
un regime di ispezioni permanente che va oltre ogni precedente regime di
ispezioni in Iran. L'accordo fornisce all'AIEA i mezzi per assicurarsi
che l'Iran non lo faccia, sia attraverso strumenti di verifica specifici
del JCPOA, alcuni dei quali durano fino a 25 anni, sia attraverso il
Protocollo aggiuntivo, che dura a tempo indeterminato. Inoltre,
nell'accordo l'Iran ha assunto impegni che includono divieti sulle
principali attività di ricerca e sviluppo di cui avrebbe bisogno per
progettare e costruire un'arma nucleare. Questi impegni non hanno una
data di scadenza”.
All'inizio della sua amministrazione, nel giugno 2021, dopo che Trump
aveva già ritirato gli Stati Uniti dall'accordo, il presidente Joe
Biden dichiarò che l'Iran “non avrebbe mai ottenuto un'arma nucleare
sotto il mio controllo”.
In una dichiarazione rilasciata l'11 ottobre, il direttore della
National Intelligence degli Stati Uniti ha dichiarato: “Valutiamo che la
Guida Suprema non ha preso la decisione di riprendere il programma di
armi nucleari che l'Iran ha sospeso nel 2003”.
All'indomani della precipitosa decisione di Trump di ritirarsi dal
JCPOA, l'Iran ha intrapreso azioni che hanno sottolineato che non si
sentiva più vincolato da alcun limite del JCPOA.
L'Iran ha ampliato il suo programma nucleare installando centrifughe
avanzate utilizzate per arricchire l'uranio e ha ridotto il monitoraggio
del suo programma da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia
atomica (AIEA). In breve, l'Iran si è posizionato per produrre un'arma
nucleare in tempi brevi.
Sebbene l'ODNI ritenga attualmente che la Guida Suprema non abbia
preso la decisione politica di farlo, una valutazione pubblicata a
luglio contiene un'omissione significativa rispetto alle valutazioni
passate delle capacità nucleari dell'Iran.
Nella valutazione
dell'ODNI del febbraio 2024 si affermava che “l'Iran non sta
attualmente intraprendendo le attività chiave di sviluppo di armi
nucleari necessarie per produrre un dispositivo nucleare testabile”.
Tuttavia, questa affermazione è sparita dalla valutazione del luglio
2024, una chiara indicazione del fatto che la comunità di intelligence
degli Stati Uniti, in gran parte a causa della riduzione delle attività
di ispezione dell'AIEA, non è in grado di comprendere gli aspetti
tecnici critici delle industrie iraniane legate al nucleare.
Il senatore Lindsey Graham, dopo aver letto la versione classificata del rapporto ODNI sull'Iran del luglio 2024, ha manifestato “grande preoccupazione” per il fatto che “nelle prossime settimane o mesi l'Iran possieda un'arma nucleare”.
Cosa si prospetta per gli Stati Uniti e Israele
Questa è la situazione che Israele e gli Stati Uniti si trovano ad
affrontare mentre decidono una rappresaglia israeliana contro l'Iran per
l'attacco missilistico del 1° ottobre.
L'Iran ha evidenziato che qualsiasi attacco contro le sue capacità
nucleari o di produzione di petrolio e gas sarebbe considerato di natura
esistenziale. Ciò potrebbe innescare l'inversione della fatwa e il
dispiegamento di armi nucleari entro pochi giorni dalla decisione.
Il presidente Joe Biden ha dichiarato alla stampa venerdì scorso di
sapere quando e dove Israele colpirà, ma si è rifiutato di dirlo. I
documenti di intelligence statunitensi trapelati negli ultimi giorni
hanno mostrato i limiti della conoscenza degli Stati Uniti su ciò che
Israele intende fare.
Gli Stati Uniti e la potenza nucleare israeliana hanno a lungo
sostenuto che un Iran dotato di armi nucleari rappresentava una linea
rossa che non poteva essere oltrepassata senza gravi conseguenze, ovvero
un massiccio intervento militare volto a distruggere l'infrastruttura
nucleare iraniana.
Questa linea è stata superata: l'Iran è di fatto una potenza
nucleare, anche se non ha compiuto gli ultimi passi per completare la
costruzione di una bomba nucleare.
Le conseguenze di un attacco all'Iran potrebbero rivelarsi fatali per gli aggressori e forse per l'intera regione.
(Traduzione de l'AntiDiplomatico)
*Scott Ritter è un ex ufficiale dei servizi
segreti del Corpo dei Marines degli Stati Uniti che ha prestato servizio
nell'ex Unione Sovietica per l'attuazione dei trattati sul controllo
degli armamenti, nel Golfo Persico durante l'operazione Desert Storm e
in Iraq per la supervisione del disarmo delle armi di distruzione di
massa. Il suo libro più recente è Disarmament in the Time of
Perestroika, pubblicato da Clarity Press.